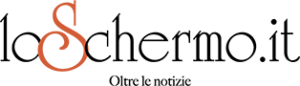“La mia purtroppo è una storia più comune di quanto si pensi, fatta di violenza, di disturbi psichiatrici mai davvero affrontati e di una totale assenza delle istituzioni: è una storia di abbandono” inizia così la storia di G, 30enne lucchese che ha deciso di ripercorrere la sua vita e metterla nero su bianco sperando che a qualcuno arrivi questo messaggio. Una vita di violenza: violenza di genere, violenza domestica, violenza sui minori, perizie psichiatriche rimaste a prendere polvere nei cassetti, assenza di tutele e un completo rimbalzare di responsabilità tra sanità, polizia e sociale.
“Tutto è iniziato quando mia madre e mio padre erano fidanzati: ebbero un incidente in macchina e mio padre picchiò mia madre e fu l’inizio di una vita segnata dalla violenza e dall’umiliazione. Successivamente quando rimase incita di mio fratello gli episodi violenti continuarono, in modo molto pesante, tanto che mia madre si decise a lasciare mio padre: aveva tutti contro, compresa la famiglia – esclusa mia nonna che era, invece, una donna emancipata -, lo stesso avvocato le consigliò di tornare a casa e cercare di far stare mio padre più calmo e quella fu la decisione che prese anche perché mio padre, lavorando in banca, era riuscito a bloccare il conto cointestato”.
“Io sono nato e cresciuto nelle violenze di mio padre, è sempre stato così: all’esterno era perfetto, nessuno avrebbe mai pensato a quello che ci faceva vivere ma quando entrava in casa gli occhi gli cambiavano immediatamente. Bastava una sciocchezza, un libro fuori posto o un po’ di polvere sopra la mensola che si scatenava il delirio: piatti lanciati, casa sottosopra, botte. Eravamo soli in quell’inferno, mia madre era cresciuta con l’abitudine di non dire, di dover apparire perfetti fuori da quelle quattro mura e i vicini, complice forse il livello culturale del posto in cui abitavamo, non hanno mai detto niente”.
Un piccolo e spaventoso mondo dentro le mura di una casa, quella casa che ogni sera si trasformava nel solito teatro dove due bambini diventavano irragionevolmente vittime di una persona che non accettava di avere dei problemi mentali e, quindi, di farsi curare: forse complice il solito e ancestrale pregiudizio di chi crede che la mente non si può ammalare.
“Alle elementari feci scrivere un bigliettino dalla maestra dove dissi “vorrei che mio padre fosse più buono” ma nessuno ci dette peso: le violenze erano sia fisiche, come quella di spaccare piatti in testa a mio fratello o riempirlo di botte per non farlo apparire a un programma televisivo in cui era stato scelto perché era il più bravo della classe , sia psicologiche come passare quei pochi momenti normali in famiglia, come una cena fuori, a sentirsi elencare per ore quanto non valessimo niente”.
“Quando avevo nove anni, dopo infinite volte che avevamo provato a lasciare casa per poi tornare – a causa anche del rapporto malato che indubbiamente mia madre aveva con mio padre – essa si mise a letto e non si alzò per 3 mesi: ero da solo, mio fratello era grande e non c’era mai, e io mi dovetti prendere cura di lei, assumere per lei il ruolo di genitore, quello che mancava tanto a me”.
Viene da chiedersi dove siano stati i servizi sociali, o chi per loro, in tutti quegli anni in cui G ha dovuto tenere sulle piccole spalle di un bambino tutto quel peso, ma questo è solo l’inizio perché il tutto ha preso una piega diversa, e dai risvolti ancora più complessi a causa di una totale mancanza di tutela da parte delle istituzioni, quando a quest’uomo è stato diagnosticato il Morbo di Parkinson.
“Alle superiori mia madre decise finalmente di lasciare mio padre, coinvolgendo avvocato a psicologo ma il giorno in cui dovevamo andarcene lui tornò a casa con la diagnosi del Parkinson e così lei non se la sentì di lasciarlo. Da quel momento tutto peggiorò, lui era altalenante – infatti si è poi scoperto essere bipolare e paranoico –e aveva momenti bassissimi, difficilissimi da gestire a causa anche della forza immensa che gli davano i medicinali”.
“Dovetti andare a vivere con loro in una nuova casa, che mio padre aveva ristrutturato come risarcimento danni praticamente, come tutti i regali che ci faceva – macchine e soldi e borse super firmate a mia madre – costretto a dormire a in salotto su un divano per sei mesi, e lì le aggressioni divennero insostenibili: dovemmo far sparire tutti i coltelli. Finalmente i vicini si accorsero di qualcosa però e furono la mia salvezza, durante le litigate mia madre non riusciva ad arginare la cosa e io urlavo il loro nome che chiamavano la polizia: come quella volta che mi minacciò di morte con un punteruolo sulla schiena. Fu in quel momento che decisi di andarmene e presi casa a Pisa, dove studiavo all’università”.
“Era il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quando mia madre mi chiamò dicendomi di trovarsi nuda in mezzo alla strada dopo essere scappata da casa perché mio padre l’aveva minacciata con un coltello. Chiamammo il numero rosa ma nessuno rispose perché tutti erano impegnati a prendere parte alla manifestazione, ci dettero appuntamento solo il giorno seguente riempiendoci di bei discorsi ma senza trovare una soluzione concreta e immediata, visto che dissero che non avevano strutture dove poter ospitare mia madre e che di mio padre dovevano occuparsene le forze dell’ordine. Andammo in questura quella sera, raccontammo tutto alla portineria perché nessuno era disponibile ma ci venne detto che il caso era segnalato: quella notte portai mia madre a Pisa a dormire da me quando, intorno alle 4 del mattino, ci chiamò la polizia dicendo che dovevamo tornare subito a casa o avremmo rischiato una denuncia per abbandono d’incapace. Mia madre successivamente se ne andò in albergo ma venne rintracciata da mio padre che iniziò a seguirla ovunque e diffamarla con il suo datore di lavoro, fu quindi costretta a trovarsi un rifugio in una casa in centro – che mio padre non scoprì mai – pagata vendendosi l’oro visto che aveva bloccato di nuovo il conto, atto illegale peraltro”.
“Successivamente mio padre, per riconquistare mia madre, aveva deciso di farsi curare a tutti i costi: ci presentammo al centro di salute mentale dove ignorarono tutto il passato e il responso fu solo “agitazione da Parkinson” legata a un problema familiare. Venne messo in un letto in Obi e infine nel reparto di reumatologia alle Barbantine, dove l’ex primario di neurologia si prese a cuore il caso scrivendo una lettera in cui affermava che mio padre aveva bisogno di una struttura protetta e idonea”.
Ed ecco che inizia così la terza violenza e la terza ingiustizia: quella sul malato psichiatrico, un figlio che è costretto a pregare e supplicare di trovare un posto al proprio padre, malato, violento e pericoloso. Responsabilità che rimbalzano da un’istituzione all’altra, senza mai una risposta concreta, fino alla morte di quest’uomo.
“La soluzione che l’UVM ci propose fu solo una lista di RSA private, inaccessibili per noi in termini economici. Così, grazie a un amico specializzando in psichiatria a Pisa, riuscii a farlo ricoverare lì per due settimane nelle quali finalmente arrivò la diagnosi che andava oltre al Parkinson. I medici di Pisa, tutti molto cordiali e umani rispetto a quelli di Lucca, mi trovarono un posto in un centro specializzato a Cascina ma, avendo la residenza a Lucca mio padre, non fu accettato. L’assistente sociale mi disse che l’unica soluzione era la presenza di un’infermiera una volta a settimana per controllare l’assunzione della cura. A quel punto inviai una lettera per chiedere le dimissioni protette e, durante la convocazione con quello che al tempo era il primario di psichiatria di Lucca e altri medici, mi dissero che avrebbero preso provvedimenti legali nei miei confronti accusandomi di abbandono d’incapace. Alla mia precisazione che mio padre non era incapace di intendere e di volere mi risposero testuali parole: “a noi cosa ci vuole per dichiararlo incapace?”
“Infine lo dimisero e, violando tutte le norme sulla privacy, lo inserirono in un centro ad Aulla, non molto costoso ma decisamente poco pratico e nonostante la perizia psichiatrica dell’Ospedale di Pisa la diagnosi era sempre e comunque: agitazione da morbo di Parkinson. Venne poi trasferito in un centro specializzato a Gravidona ma potettero tenerlo solo qualche settimane, una volta tornato a Lucca decisi -visto che dopo tutto l’iter tra sociale, sanità e forze dell’ordine nessuno mi aveva considerato – di rivolgermi direttamente al Sindaco Tambellini. Lui mi ricevette in tempi brevi e nonostante si presentò molto carino e umano nei confronti della vicenda, non risolse niente e non lo sentii più dopo quell’incontro”.
“Fummo costretti a mettere mio padre in un centro privato a Lido Di Camaiore, alla modica cifra di 3300 euro al mese e vendemmo tutto quello che avevamo per poterci permettere una tale spesa”.
“La storia si conclude con la morte di mio padre, all’ospedale Versilia e a fronte di tutta questa odissea io non posso che essermi sentito abbandonato completamente da tutti i protagonisti di questa vicenda. Sono passato trasversalmente da reparti psichiatrici, sanità, forze dell’ordine e amministrazione comunale e ciò che ho riscontrato è un sistema completamente fallimentare. Avrei solo voluto che venissero riconosciuti a mio padre i problemi psichiatrici che aveva, che non venissimo trattati come quelli che non vogliono occuparsi di un malato in casa, che mi tutelassero. Ho vissuto nella violenza: prima l’ho vissuta come un bambino vittima di un padre che lo picchiava, ho visto mia madre venire massacrata da mio padre e infine ho visto il menefreghismo di chi dovrebbe risolvere queste situazioni”.
G sta bene ora, almeno fisicamente, e con fatica e sofferenza ha rimesso insieme tutti i pezzi di quella vita complessa che ha dovuto affrontare lasciandosi alle spalle quel fardello di responsabilità di cui, fin da piccolissimo, si è fatto carico.
Ma non è un caso isolato, storie come queste sono all’ordine del giorno tra le quattro mura delle abitazioni e non sempre finiscono bene, non sempre possono essere raccontate.
“Io potevo essere morto, come potevano esserlo mia madre e mio fratello – conclude G – se ci troviamo di fronte a un sistema di tutele completamente assente, se anche la stessa Polizia ci ha sempre detto ”siete sicuri che volete denunciare?” non scandalizziamoci poi di fronte alle tragedie”.
Un invito, quello del protagonista della storia, ad andare oltre la forma e i luoghi comuni sulla violenza incrementando un sistema che veramente stia vicino a queste persone, in cui le istituzioni competenti – oltre a comunicare tra loro senza nessun esito concreto – siano pronte a fornire soluzioni reali e immediate alle vittime, perchè solo così potremmo smettere di piangere le tante morti tra le mura di casa.