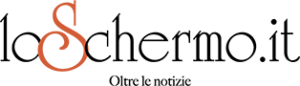In questi giorni un articolo di Antonio Polito sul Corriere della Sera titolava “Non facciamolo strano” (ebbene sì, c’è un diretto riferimento al film di Verdone) riguardo alle ipotesi di riforma del sistema di governo e all’idea di premierato. La tesi portata avanti era quella che, per garantire la possibilità di approvare una riforma di cui comunque riconosceva la necessità, bisognerebbe accorciare le distanze tra le parti politiche eliminando l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. E la motivazione era che bisognerebbe superare “il principale limite del testo del governo, «che è quello di partire dall’elezione diretta del primo ministro anziché dalla definizione dei suoi poteri… in materia di fiducia, sfiducia, indizione di elezioni anticipate, nomina e revoca dei ministri»”.
In altre parole il tema sarebbe che l’elezione diretta sarebbe il male da togliere dalla proposta; i poteri rafforzati la necessità giusta e utile da salvare.
E viene da chiedersi: perché l’elezione diretta è un male in sé? Cioè è facile capire che uno possa non concordare con la tesi che il capo del governo debba avere più poteri. La concentrazione di poteri nelle mani di un uomo che possa anche determinare tutta la compagine ministeriale è un elemento che può legittimamente creare un dubbio. L’esperienza di gran parte del mondo democratico mostra che non si corrono poi troppi rischi ma almeno l’obiezione sarebbe comprensibile. Ma l’elezione diretta che rischio comporta?
Se poi guardiamo al resto del nostro ordinamento, il dubbio sale ulteriormente di livello.
Nei comuni abbiamo che il sindaco sceglie la sua giunta. E il sindaco è eletto direttamente. Non era così storicamente: prima il sindaco era eletto dal consiglio comunale ed era ostaggio dei giochi dei partiti in consiglio. I conseguenti frequenti cambi di sindaco all’interno di una consiliatura rendevano poco incisivo e non efficace il lavoro della politica. Fu così che nel 1993, in piena tangentopoli, il parlamento approvò la riforma e il sindaco fu eletto: aveva il potere di sciogliere, con le sue dimissioni, il consiglio, di nominare i membri della giunta e fu introdotto il premio di maggioranza. Parallelamente fu introdotto il limite dei due mandati. La cui giustificazione era (ed è) quella di evitare che il troppo tempo al potere porti a delle incrostazioni tra politica e amministrazione.
Il risultato fu di grande soddisfazione: nessun partito oggi pensa che sia meglio tornare alla gestione precedente.
Poi è stato il turno delle regioni: storia analoga; analoghi risultati; analoghe garanzie (limite dei mandati). Analoga è stata anche la soddisfazione di politica e cittadinanza. Analogo infine il fatto che nessuno vorrebbe tornare all’epoca dei presidenti eletti in seno al consiglio regionale.
Quando però si arriva a livello nazionale scatta qualcosa. Qualcosa di strano. D’improvviso quello che ha dimostrato efficacia nei livelli inferiori viene visto come negativo. E, soprattutto, lo strano è che ciò che viene contestato non è l’aumento del potere del Presidente del Consiglio quanto piuttosto la sua investitura popolare: il voto diretto. Voto che si vorrebbe togliere o anche solo depotenziare, secondo la proposta presentata nell’articolo sopra ricordato, inserendo sì il nome del candidato presidente nella scheda ma facendolo come semplice proposta senza valore vincolante. Quest’ultima sì che sarebbe una vera stranezza.
E questa paura del voto nominativo è strana perché l’elezione diretta ha come scopo l’aumento della responsabilità personale dell’eletto, a parità di poteri attribuiti. In altre parole, eleggere direttamente il Presidente del Consiglio ne limita l’uso dei poteri, non li amplifica. Li limita perché per ogni errore ne paga direttamente il conto. Quindi lo responsabilizza personalmente, gli ci “fa mettere la faccia”. E, ancora più stano, il dibattito non si è infiammato sul numero massimo di mandati che un capo del governo potrà fare. Limite che inizialmente non era neppure previsto. Ma il dibattito dalle opposizioni non si è acceso su questo, bensì sull’elezione diretta. E curiosamente (ma forse non troppo…), l’unica cosa su cui si misura un avvicinamento tra pezzi della maggioranza e pezzi dell’opposizione è sull’ipotesi di allungare il numero dei mandati. Cioè il tempo che si può stare al potere. Oggi lo si propone per i governatori e domani per i sindaci.
È difficile non pensare male. E, seguendo il motto di Andreotti (che di potere se ne intendeva), a pensar male si farà anche peccato ma ci si indovina davvero spesso. Allora viene da pensare che il vero motivo di tanta acredine verso l’elezione diretta del capo del governo è che questa tolga un importante spazio di manovra ai navigati leader di partito. Che in transatlantico hanno soggiornato per gran parte delle loro vite e che in quel luogo, di stucchi e divani, hanno fatto e disfatto una gran quantità di governi. E hanno accumulato un potere giustificato più dalle loro capacità di ordire congiure e ribaltoni del voto popolare che da quella di proporre idee e progetti.
Un potere che il premierato metterebbe in discussione.
E questo è già di per sé un valido motivo per sostenerne le ragioni. Maggiormente se, come appare probabile, l’elezione dovrà essere confermata in un referendum.
Poi resta fortissima la necessità di riportare ad elezione diretta anche i parlamentari. Ma questa è un’altra faccenda e non sarà affatto facile…