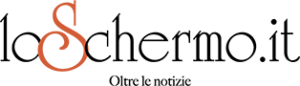In questa campagna elettorale dai toni eccitati, uno dei casi più curiosi è quello di Letta e del PD.
Veramente difficile seguire il filo conduttore della loro strategia (ammesso che strategia ci sia).
Prima si stracciano le vesti contro Conte, reo di una manovra parlamentare assai azzardata, pessimamente condotta e, fondamentalmente, suicida. E fin qui si può capire il desiderio frustrato di restare al governo e lo scorno per essere stati fatti fuori dal proprio alleato.
Talché Letta dichiara che con Conte non è più possibile lavorare, che si è rotto il patto di fiducia e che quindi non ci potrà essere alcun accordo elettorale.
Ma se questa è una posizione istintivamente comprensibile, politicamente è assai problematica. Perché equivale a rinunciare a quella forma di meccanismo anti-frammentazione della legge elettorale che sono i collegi uninominali (per 1/3 del totale). E quindi a dare un vantaggio enorme al centrodestra.
Come conseguenza, il nostro si lancia in quella che sembra una scelta tattica: l’accordo con Calenda. E per arrivare a chiuderlo accetta condizioni capestro, riconoscendo al nuovo alleato un peso che neppure i sondaggi più favorevoli gli danno.
Questa poteva essere una mossa strategica: spostare l’asse della coalizione un po’ più al centro, con la scelta degli alleati, riservando al PD il ruolo di unico attore credibile che possa interprete la sinistra del paese. E contendere così lo spazio che Conte si andava ritagliando. Oltretutto Letta aveva appena rifagocitato i fuoriusciti di Articolo 1 e quindi non c’erano padri nobili della sinistra fuori dal PD.
A questo punto della storia qualcosa si rompe. Non è chiaro se nella testa di Letta emerge una paura atavica della sinistra contro o se, da ex-DC, non riesce a riconoscersi nella leadership di un partito che diviene più sinistra che centro-sinistra, ma improvvisamente cerca degli alleati da quella parte.
E non va a cercare l’unico partito che ha una certa consistenza, ossia i 5 Stelle. No. Cerca degli improbabili interpreti come Fratoianni e i Verdi. Roba che, messa insieme, rischia di non arrivare neppure all’uno per cento e quindi di non portare neppure le briciole (nell’attuale legge elettorale, i voti dei partiti che non raggiungono l’1% non vengono contati nella coalizione…).
Quindi un’alleanza irrilevante nei numeri ma pesantissima nel segno politico. Perché porta in seno alla coalizione chi ha sempre osteggiato il Governo Draghi nel nome del quale il PD ha escluso i 5 Stelle.
A questa scelta segue anche quella di non fare alleanze con Renzi e Italia Viva. Anche qui la motivazione appare incomprensibile se non sul piano delle avversioni personali. Tipo: “caro Matteo, stai sereno”. Cosa comprensibile (in politica, e non solo, Renzi ha collezionato una imponente quantità di detrattori e nemici) ma, sul piano razionale, autolesionista.
Infine, la scelta di non fare più una coalizione ma un curioso “cartello elettorale”.
Un cartello elettorale? Che roba è! Tipo accattonaggio di voti?
Quindi: che senso ha avuto escludere i 5 Stelle?
Perché prendere Fratoianni e rifiutare 5 Stelle se il discrimine era il sostegno al Governo Draghi?
E se non lo era, quale era il vero discrimine?
«A pensare male si fa peccato ma ci si indovina quasi sempre» diceva il Giulio Massimo del secolo scorso. E allora, consapevoli che potremmo sbagliare, ci viene naturale pensare che il discrimine siano state le personali antipatie del segretario Letta.
Non è certo un segreto per nessuno che Letta avesse una partita aperta con Renzi il quale gli fece le scarpe quando era a Palazzo Chigi.
Ed era evidente che Letta abbia considerato un affronto il comportamento di Conte durante la corsa per il Quirinale.
Il fatto che poi, quella volta, Letta abbia vinto, ottenendo la riconferma di un ex-PD al Quirinale, non toglie lo smacco di non aver potuto guidare l’alleanza di centro-sinistra nella trattativa. A questo affronto è seguito quello che ha portato alla crisi di governo, dove l’incontro “privato” tra Letta e Conte non ha portato il secondo a farsi guidare dal primo. Il che ha portato il primo a scomunicare il secondo.
Tutto molto bello e interessante ma di logica politica non ce ne è neppure un briciolo.
Su queste basi, è facile capire lo scarto di Calenda, seppure mal gestito sul piano comunicativo.
E quella frattura ha portato il PD ad essere di fatto l’unico partito dell’ex campo largo. E il cartello elettorale è diventato qualcosa di indefinibile: c’è un partito, che è il PD, e una serie di soggetti aspiranti a qualche poltrona senza vere ambizioni di risultati. Sarà interessante vedere quanti di loro arriveranno al mitico 3% (quota per aver accesso a qualche parlamentare) e quanti addirittura non raggiungeranno neppure l’1%.
Poi è cominciata la campagna elettorale. E il “cartello” non ha avuto nessuna possibilità di definire contenuti condivisi. Neppure quelli che tradizionalmente sono del PD. Ognuno racconta la sua storia, le sue idee, come se potesse poi realizzarle, come se non facesse parte di una “coalizione”.
Parallelamente, con il silenzio minaccioso dei maggiorenti PD nei confronti di Letta, è partita la rincorsa al riavvicinamento con Conte e i 5 Stelle. Ma, ormai, per il dopo elezioni, cioè per quando i giochi saranno fatti. Sempre che, questo cervellotico sistema elettorale, non produca ancora una volta un “non risultato” come quello del 2018.
Così, mentre la campagna elettorale impone di dire che i 5 Stelle non sono affidabili, le comunicazioni indirette (ma ben visibili) portano a dire che dopo la campagna (dopo la sconfitta?) ci sarà un altro tipo di ragionamento. Come se, dopo la sconfitta elettorale, Conte dovesse essere più affidabile di un mese fa.
Di questo passo va in scena una campagna fatta di… nulla. Non una vera idea con cui confrontarsi. Non un tema portante. L’unico elemento ricorrente è il ricorso ai fantasmi di un passato assai remoto: il fascismo.
Ecco, quindi, la polemica sulla fiamma (che non era un simbolo fascista ma di AN che, a sua volta, era stata sdoganata anche dalla sinistra) e i manifesti in rosso e nero: comunismo contro fascismo.
E via con il tentativo di polemizzare sul nulla, come quando ci si aggrappa a questioni semantiche per l’uso improprio (dentro un discorso assai più lungo) dell’uso del termine “devianza”. E con Letta che, come un ultras qualunque, se ne viene fuori con un “viva le devianze”, quest’ultima frase sì, da brivido.
E poi giù a parlare di voto utile per minare le possibilità di un terzo polo che avrebbe potuto avere come alleato se solo lo avesse voluto in una prospettiva politica ragionevole. Mentre, dall’altra parte, un silenzio verso i 5 Stelle che assomiglia più ad una resa sulle idee condita da una aria elitaristica e snob. Mentre è assente una qualunque strategia di contenimento di un avversario che aggredisce direttamente l’elettorato PD. Un silenzio che agevola il compito dei grillini di accreditarsi come “la vera sinistra del paese”. Sempre che si possano ancora definire “grillini”.
E poco importerà se poi alla fine il PD avrà qualche voto in più di FdI. E neppure che le atre forze con cui, dopo le elezioni, sarà possibile fare accordi (5 Stelle e Calenda-Renzi) prenderanno alla fine anche qualche voto in più degli alleati della Meloni. Perché, per effetto del maggioritario, il centrodestra avrà la maggioranza in parlamento. E le alleanze del giorno dopo le elezioni, in questo caso, non serviranno a molto. A parte il fatto che l’idea di presentarsi divisi per governare insieme, è un insulto al concetto di sovranità del popolo.
La sensazione complessiva che si ricava da questa analisi delle decisioni di Letta è quella di una gestione più umorale che intellettuale, priva di una vera strategia e destinata alla sconfitta.
C’è un detto che recita: “chi sa fa, chi non sa insegna”.
Se il risultato elettorale sarà quello che oggi appare più probabile, è facile immaginare che Letta potrà tornare a insegnare politica ai francesi di Science Po.
(Foto di copertina da DonkeyHotey Enrico Letta – Caricature – flickr.com)
Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi