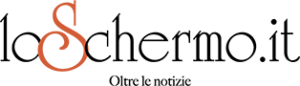C’è una strana convinzione nella politica: che due torti possano fare una ragione.
Quindi se qualcuno ha subito un torto allora si potrebbe “fare pari” facendogli avere un ingiustificato vantaggio ai danni di qualcun altro senza neppure chiedersi se questo terzo c’entri o meno con il torto subito.
È il caso della questione femminile.
Si è affermata la convinzione che la soluzione al problema della questione femminile possa essere l’istituzione delle quote rosa.
Che poi vuol dire fare un’autostrada di privilegi per le poche che sono presenti e non cercare neppure di capire perché siano poche e perché le altre si tengano lontane. Vuol dire cioè lavorare sui sintomi e non sulle cause della malattia.
Cerchiamo di essere più specifici.
Parliamo dalla politica (ma il ragionamento è lo stesso anche per i ruoli dirigenziali nel mondo del lavoro).
Osserviamo che in politica le donne sono poche.
Molto poche.
E questo è male. Non ci vuole molto ad arrivarci.
La reazione dovrebbe essere quella di cercare di capire perché sono poche.
È perché le donne hanno qualche cosa di meno o di diverso per cui la politica non le attrae o non sono in grado di farla bene?
La ragione, e la nostra conoscenza della vita, ci porta a rifiutare nettamente questa ipotesi: non c’è nessun settore in cui le donne non abbiano potuto dimostrare che il loro intelletto sia equivalente (nelle differenti sensibilità) a quello maschile.
O, allora, è perché c’è una “conventio ad excludendum”, un accordo tra tutti gli attori uomini, che vogliono difendere il loro privilegio?
L’ipotesi è anche da considerare. E certamente, almeno in termini di pregiudizio piuttosto che di deliberato piano concordato, ci sono stati ostacoli maggiori per le donne anche in un passato recente. Però appare oggi assai difficile considerare che questa ipotesi sia sufficiente a spiegare il “gender gap” che si misura in politica (su questo punto, però, in alcuni settori del mondo del lavoro, a differenza che nella politica, il problema è assai concreto).
Questa sommaria analisi è più o meno tutto. Non ci sono state analisi molto più approfondite che abbiamo avuto eco nel dibattito pubblico.
A questo punto la diagnosi, non essendo stata trovata tra le osservazioni banali, non è interessata più a nessuno. La risposta più facile è stata trovata tagliando la testa al toro (come si usa dire in queste circostanze): “imponiamo un numero di donne adeguato per legge e chissenefrega del problema. Così si dà una risposta e nessuno può dire che non ce ne siamo occupati. Costa poco (qualcuno ci lascerà il posto – ma tanto la politica è una giungla –, e qualcuna vincerà la lotteria di capodanno) è una soluzione presentabile e non c’è necessità di affrontare nessun vero e complicato problema”.
Tutti felici.
Ok, ma la domanda è rimasta inevasa: perché poche donne si avvicinano alla politica?
Oggi, tra le leggi di quote rosa e l’opinione pubblica, essere donna in politica è un vantaggio enorme. Eppure… le donne sono ancora poche.
Quindi: perché?
Non farsi questa domanda e pensare che le quote rosa siano una valida risposta è come cercare di curare un paziente malato di broncopolmonite dandogli un potente calmante per la tosse. Il paziente (forse) tossirà meno. La malattia (di certo) non regredirà. Il paziente morirà di broncopolmonite.
Le quote rosa sono il nostro calmante: attacca (e pure male) i sintomi e non fa nulla per aggredire le cause.
Se cerchiamo le cause, non possiamo non vedere che hanno a che fare con una diversità “naturale” che c’è tra uomo e donna.
L’uomo non partorisce.
La donna sì.
È un vincolo che porta le donne ad essere più legate alla vita dei figli, soprattutto nei primi anni di vita. È un legame che orienta le scelte che queste fanno in ordine al proprio futuro. E le porta a “sacrificare” alcune aspettative di carriera (politica o lavorativa) per garantire una maggiore “copertura” per i figli.
Pensare che non esista e che possa essere superato solo perché ci sono delle magnifiche opportunità significa non comprendere quanto questo legame sia forte.
E quindi le quote rosa sono una doppia ingiustizia: la prima perché non risolve il problema di chi fa una rinuncia per non lasciare soli i propri figli, la seconda perché queste stesse donne si vedono superare non da chi è meglio di loro, ma solo da altre donne che hanno fatto scelte diverse e si trovano avvantaggiate esclusivamente in virtù delle conseguenze negative sopportate dalle prime.
Allora che fare?
Il primo punto è capire che, almeno in parte, il problema non è risolvibile: non possiamo pensare che tra madre e figlio non ci sia un legame molto forte soprattutto nei primi anni. E questo legame porterà inevitabilmente qualche limite “in media” alle carriere delle donne.
Ma poi dobbiamo anche focalizzare un punto: i figli sono un carico per la famiglia non solo i primi anni ma fino all’età adulta.
Nei programmi elettorali, ciclicamente, qualcuno propone asili nido gratuiti (per lo più come soluzione al problema della natalità bassa; come se uno non facesse figli perché per tre anni deve trovare loro un asilo). E anche questa volta, c’è chi propone la misura (lasciando perdere il fatto che nessuno dice mai dove recuperare le coperture economiche anche per interventi relativamente piccoli come questo).
Il punto è che dopo l’asilo i figli richiedono ancora una cura attiva da parte della famiglia per almeno altri tredici anni. E se una famiglia fa più di un figlio, questo tempo si allunga sensibilmente.
Se vogliamo rimuovere il problema del gender gap dobbiamo partire dal coordinare i tempi del lavoro con quelli della delega alla cura dei figli. Ossia dobbiamo far sì che le famiglie non debbano scegliere chi deve fare rinunce nella carriera per stare a casa il pomeriggio, visto che i figli escono da scuola e non possono certo stare da soli. Perché se lasciamo le famiglie nella necessità di fare questa scelta, allora il risultato sarà che, per lo più, saranno le donne a stare a casa. In virtù di quel legame speciale già menzionato.
Quindi, a mio avviso, abbiamo davanti un bivio: o ci teniamo un sistema condiviso di educazione dei minori in parte a carico dello stato (con la scuola) in parte a carico della famiglia (con i compiti e i pomeriggi a casa), ma allora ci teniamo anche il gender gap, o affrontiamo il gender gap e mettiamo materialmente le famiglie nella condizione di non dover scegliere chi, al proprio interno, deve seguire i figli.
Nel primo caso le quote rosa sono un triplo errore: danno delle opportunità immeritate a chi non ha bisogno di supporto (perché non ha vincoli particolari o ha risolto differentemente il problema), mortifica chi (sempre donna) non può sfruttare le opportunità presenti per scelte familiari ed è sbagliato nella quantità perché la “parità tra uomini e donne” non può essere 1 a 1 (visto che abbiamo accettato come ipotesi che molte famiglie decideranno di tenersi i bambini e quindi prevalentemente lo faranno le donne).
Nel secondo, dobbiamo affrontare le inevitabili resistenze sindacali di insegnanti e mondo della scuola che non ne vorranno molto sentire parlare di lavorare 8 ore al giorno, ma potremmo cercare di risolvere fattivamente il problema. In questo contesto avrebbe anche senso parlare di quote rosa (o meglio di quote parentali) se lo si facesse per ridare slancio a carriere interrotte per un periodo limitato (uno o due anni) spesi nella cura dei neonati.
È evidente che le implicazioni da valutare e affrontare vanno oltre quanto detto (basti pensare alla necessità di una fattiva libertà di scelta di un modello educativo).
Ma questo è il punto attorno al quale cominciare a riflettere: il superamento del gender gap richiede un approccio diverso all’organizzazione della vita e in particolare nella gestione dell’educazione dei figli. E quindi passa da una diversa organizzazione della scuola e dei tempi dei ragazzi che delle famiglie sono il principale impegno organizzativo (oltre che economico).
Altrimenti dobbiamo accettare il fatto che significative percentuali di donne non faranno e non faranno parte del mondo del lavoro, non cercheranno attivamente di partecipare alla vita pubblica e, in generale, non vorranno/potranno compiere percorsi di vita che richiedono una partecipazione attiva intensa.
La vera parità è quella che consente ad una donna (a ciascuna donna, indipendentemente da altri fattori come rete familare o disponibilità economiche) di scegliere di essere madre senza che questo debba per forza essere l’unico ambito di piena realizzazione.
Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi