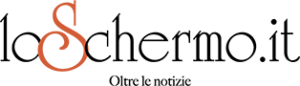“La moralità non deve inficiare l’arte”: è con queste parole di Stenio Solinas che si chiudono i tre giorni di giornalismo, editoria, cultura e audacia di Libropolis. Solinas è stato infatti il protagonista, insieme a Giampiero Mughini dell’ultimo incontro del Festival, dal titolo “Vite Parallele di Due Irregolari” moderato da Carlos D’Ercole.
I due, controversi, affascinanti e dibattuti intellettuali dei nostri giorni, hanno entrambi vissuto per intero, nel dopoguerra, la stagione dell’attivismo intellettuale e militante a destra come a sinistra. Entrambi, nella loro carriera di giornalisti e scrittori, hanno tentato di oltrepassare quel recinto ideologico in cui sono nati, quella retorica in cui sono cresciuti cercando altrove, in altre terre e in altri luoghi dello spirito, un’avventura individuale che gli ha permesso di guardare il mondo con disincanto ma con lo stesso impegno culturale.
L’interessante dibattito, un viaggio nell’ultimo secolo del giornalismo, ci ha condotti a un ragionamento più approfondito su quello che che noi facciamo attraverso la “penna”, con passione e dedizione, ma soprattutto su tutte quelle circostanze che girano intorno a questo affascinante mestiere che, in continuo divenire, è, oggi come allora, l’unico strumento da dover proteggere e salvaguardare in nome di una libertà di cui siamo schiavi.
Schivi della libertà? Sì: parlare di libertà è indubbiamente bello ma estremamente banale, retorico e a tratti semplicistico. Celarsi dietro questo termine, che racchiude una serie di significati inimmaginabili, è ormai lo scudo di chi un’identità vera e propria non ce l’ha, di chi, in nome di un’ideologia che fa da monito, si perde nel caos di giochi di potere.
“Sono uno che è nato in ritardo” – ha affermato Stenio Solinas durante la conferenza – “per me la grande stagione dell’Italia e il grande interesse si riversava su quel periodo tra le due guerre mondiali e si configurava in quella che era stata l’espressione politica del tempo e cioè l’avventura del fascismo che è, a tutti gli effetti, un grande buco nero per la nostra nazione. L’italia, che se l’è cavata dicendo che la guerra l’aveva perduta il fascismo, in realtà non ha mai vinto perché sono gli stessi italiani ad aver perso non avendo mai voluto fare i conti davvero con questa esperienza”.
Quello di cui Solinas parla è tremendamente attuale, in un’Italia uscita dal conflitto mondiale tutti erano affascinati dallo scoprire chi davvero fossero stati i protagonisti, ma allo stesso tempo raccontare e studiare il fascismo era oggettivamente impossibile, tanto da doversi trovare costretti a indossare dei panni lontani dal proprio credo profondo per approfondire l’argomento. Questo ha portato a una dicotomia dispotica in cui la destra si è caricata di quel sigillo fascista per cui nessun giornalista o scrittore del tempo si dichiarava di quella sponda per paura e che ancora adesso porta le conseguenze nell’attuale società in cui viviamo. “Quando oggi sento dire che non è esistita un’egemonia culturale della sinistra devo per forza ammettere che si tratta di un errore: è esistita ed è stata spietata” continua Solinas.
Erano gli anni ’60 quelli che il giornalista ricorda e il terrore di un movimento estremo come il fascismo ha lasciato in ogni essere umano una tendenza feroce verso tutto ciò che poteva anche lontanamente riportare ad esso ma, tralasciando per un attimo destra e sinistra, che oggi restano solo termini per indicare la strada a un passante, è importante soffermarsi su quanto il lavoro del giornalista, ieri come oggi e probabilmente anche domani, sia estremamente soggetto alla strumentalizzazione politica.
A livello deontologico, e spiegato in modo semplicistico, la professione giornalistica dovrebbe basarsi solo ed esclusivamente sul racconto dei fatti reali, non soggetti ad interpretazioni: una base difficile oggettivamente da rispettare, soprattutto oggi in una società lasciata alla libera interpretazione e all’improvvisazione, ma non per questo impossibile da realizzare. L’ideologia politica, a prescindere da quale essa sia, grava come un macigno sulla carriera di ogni professionista della penna, inficiandone senza ombra di dubbio sulla professionalità, cosa che non succede in altri mestieri: abbiamo mai sentito dire “quel medico non lo scelgo perché è di destra?”. Ed è così che nella mente di un giovane giornalista o aspirante tale si fa spazio sempre più quella forzata consapevolezza per cui ciò in cui crediamo, o crediamo di credere, diventa lo strumento che ci indica la via da seguire: ben venga se le nostre idee ci indicassero la strada, molto male però se a farlo è una logica di mercato per cui il talento e la professionalità vengono messe all’angolo da appartenenze che non hanno ormai più senso di esistere in un’Italia ormai orfana di idee e partecipazione.
“Cominciai a scoprire che in Francia c’era una letteratura che sfuggiva alla dicotomia fascismo/antifascismo e che si inseriva in un intreccio culturale di una ricchezza tale dove erano presenti personalità unite da straordinari legami amicali e intellettuali, nonostante lo scontro ideologico. Per questo sono andato in Francia, per cercare quello che in Italia era impossibile trovare” ha spiegato Solinas riguardo il cuore pulsante del suo “Atlante ideologico sentimentale” che si traduce proprio nella città di Parigi.
Ma, dopo più di 50 anni, in Italia è davvero ancora così? Ci troviamo ancora di fronte a uno scontro ideologico che mina i reali intrecci intellettuali in nome di un passato che non abbiamo vissuto ma che, come un’ombra nera, gravita sopra di noi rendendoci schiavi di un qualcosa che mai abbiamo davvero affrontato? È scontato, e anche sacrosanto essendo in un paese democratico, che ad oggi esistano più realtà editoriali, ognuna con la la propria linea ideologica e con il proprio carattere e le proprie tendenze ma è bene ricordarsi che il giornalismo non ha e non deve avere colore: se da una parte si parla di una destra vista come minacciosa e pericolosa, dall’altra quell’egemonia culturale della sinistra è ancora presente ed è inutile negarlo. Riuscire a farsi spazio in questo mare di incertezze risulta, a noi giornalisti, estremamente difficile e pericoloso, basta un passo falso e sei fuori ed è in questo modo che si traduce la spietatezza di cui parlava Solinas. Perché, se per destra si etichetta quel sovranismo proprio di un’altra epoca, esiste una sinistra che porta con se il vittimismo dei tempi che furono e che, colma di rabbia e rancore, non lascia spazio alla libertà di scelta traducendo anch’essa in un’imposizione innaturale per la professione giornalistica.
Ed è così che la strumentalizzazione politica diventa l’unico vero motore di una professione, è così che i giochi di potere diventano i reali protagonisti delle vicende, è così che le prime pagine sono ormai lo specchio di quel consenso che, ad ogni costo, deve muovere la società. Un consenso becero e spesso ignorante, un consenso che si basa sul “sentito dire”, su condizioni non approfondite, su persone pronte a puntare il dito solo per il gusto di dire la propria opinione. Si trasformano così i giornali i contenitori di retorica, di eccessivi perbenismi, di banali tartufismi, riducendo tutto quello che dovrebbe essere cultura in uno scontro isterico e iracondo.
In un’Italia in cui nessuno si definisce più comunista e fascista, dove il civismo assume quell’aspetto patinato di chi sa prendere le giuste decisioni, quando invece si dovrebbe avere l’umiltà e la consapevolezza di affermare che si tratta di un’unica e sola scelta obbligata in un paese spoglio di credenze politiche e ideologie, dove la diplomazia è ormai imperativo, è davvero possibile compiere un mestiere in nome della verità?
Che poi di verità mica ce n’è una sola, ogni storia, ogni vicenda, ogni accadimento ha infinite verità a seconda dall’angolazione in cui essi vengono guardati, un’angolazione che un giornalista deve calibrare bene, un punto di vista che ora come ora è più importante del fatto stesso, una visione che identifica e, allo stesso tempo, stigmatizza. Perché oggi questo “vedere le cose dal lato giusto” risulta davvero essere l’unica cosa che conta, risulta davvero essere il metro di giudizio della professionalità, risulta essere l’unico lasciapassare verso realtà alte e inarrivabili.
Ed è triste ammettere che per la maggior parte dei giornalisti ormai, soprattutto i più giovani aspiranti tali, non è più un “scrivo per quello in cui credo” ma “credo a ciò, per poter scrivere”. Non vogliamo parlare di dittatura culturale o intellettuale, sono termini di cui spesso ci riempiamo la bocca ma che rappresentano solo sensazionalismi inutili e poco esplicativi, anche perché questa imposizione, alla fine, non è frutto di nessuna particolare o specifica forza politica ma rappresenta solo ed esclusivamente una dinamica comune per cui sia quella destra che quella sinistra, ormai probabilmente non più degne nemmeno di questa identificazione che rappresenta la storia della nostra Italia, sono schiave di un passato in cui è più facile rimanere attaccati che trovare le giuste modalità per trasformarlo in un’occasione per il futuro.
Quello di cui oggi siamo schiavi è solo ed esclusivamente la libertà: una libertà apparente in cui pensiamo di poter dire tutto e in cui crediamo di poter essere tutto. La stessa smania di libertà del dopoguerra, in cui tutti erano ammaliati da una nuova era, vista come quella dorata, ma che in realtà si è rivelata come la fine di un periodo storico irripetibile: quando tutto stava nascendo in realtà era già finito, quando la libertà sembrava a portata di mano, eravamo già tutti schiavi di un passato che non ci siamo scelti ma che abbiamo deciso di tenerlo presente, un passato che non è storia ma che si traduce nella più misera attualità dei nostri giorni.
Esempio lampante è Veltroni che in un’intervista di qualche anno fa ha affermato “non sono mai stato comunista nella mia vita”, a dimostrazione che la presenza di un passato ingombrante ha permesso di soggiogare l’identità delle persone e ancora oggi ci da il permesso di cancellare ciò che siamo stati, ci da l’autorizzazione di essere ogni giorno qualcosa di nuovo e di effimero.
“All’inizio del 2000 si chiude una pagina, ed è la fine di un’epoca in cui fare il giornalista era un bel mestiere e ne valeva la pena” ha affermato Giampiero Mughini durante il dibattito a Libropolis. Sicuramente l’offerta culturale del secolo scorso è stata decisamente più proficua di quello che siamo costretti a vedere oggi, ma soprattutto la differenza sta nella fame che le persone avevano: la fame di futuro, la pazienza di saper attendere il momento giusto, la consapevolezza di appartenere al proprio tempo, la paura di non avere l’occasione. Oggi tutto ciò è sottovalutato, oggi nessuno è più affamato, complice una società bulimica che apparentemente ci sazia ma che in realtà ci svuota sempre più.
“La lentezza ha ancora un valore, la frenesia è perdita di gusto. Scrivere è essere liberi, è essere Re ed essere Re non è un mestiere” scrive Stenio Solinas nel suo Atlante ideologico sentimentale.
Fin quando non ci fermeremo e smetteremo di affannarci per capire la parte giusta nella quale stare, fin quando non ritroveremo la passione nel credere davvero in qualcosa, fin quando non ci sarà qualcosa in cui credere davvero, fin quando correremo senza il coraggio di voltarci indietro, fin quando saremo i primi a non prenderci sul serio, noi giornalisti non avremo grandi strade da percorrere. Schiavi di una libertà che apparentemente ci fa sentire protetti ma che in realtà ci impone di sacrificare chi siamo per chi vogliamo diventare.