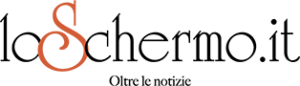Se c’è una cosa che possiamo asserire con sicurezza è che nella vita ci abituiamo a tutto. La storia ci insegna che ogni condizione, positiva o negativa, porta gli uomini ad abituarsi e adattarsi all’ambiente circostante: è semplicemente questione di sopravvivenza.
Nessuno un anno e mezzo fa pensava di affrontare quello che abbiamo e stiamo ancora vivendo con il Covid e un domani, quando lo racconteremo ai nostri figli, sembrerà sicuramente ancora più tragico e amplificato e questo perchè quando ci ritroviamo a vivere una guerra sulla nostra pelle il nostro punto di vista cambia.
Di guerra ne abbiamo parlato, in un’intervista esclusiva, con chi ha dedicato la vita ad essa: Gian Micalessin, ospite del secondo appuntamento del festival L’Augusta – La Fortezza delle Idee, dal titolo “La Guerra in mezzo a noi”. Insieme a lui, in un acceso dibattito tra geopolitica e giornalismo, a intrattenere i molti presenti, il reporter Franco Nerozzi, l’ammiraglio Nicola De Felice, il docente di economia ambientale Gian Piero Joime e il giornalista Andrea Palladino.
Giornalista di guerra da 40 anni, Micalessin, ha calpestato tutti i teatri di guerra degli ultimi anni della nostra storia: dall’Iraq alla Siria, fino al sanguinoso genocidio in Ruanda, non risparmiandosi una Sarajevo assediata, solo per citarne alcuni.
Sguardo consapevole e quella tenera sicurezza che non ha però la necessità di mostrarsi a tutti i costi: in un giornalismo sempre più in posa, Micalessin rappresenta forse quella figura che ci fa ripiombare nella realtà brutale, atroce, normale e sorprendente.
Partito a poco più di 20 anni per l’Afghanistan, insieme ai due amici e colleghi, Fausto Biloslavo e Almerigo Grilz, in quella folle missione frutto del coraggio e della meravigliosa incoscienza propria di quell’età, dopo non si è più fermato diventando così uno dei principali giornalisti di guerra a livello nazionale e internazionale.
Come e perchè hai scelto di raccontare la guerra?
Ero affascinato dalla guerra fin da ragazzino, essendo degli anni ’60, quando c’era la guerra in Vietnam, ricordo che da piccolino chiedevo a mio padre di farmi vedere le notizie in tv, che seguivo con molta attenzione. Mi affascinava per natura e perchè ero nato a Trieste, dove in quegli anni si viveva sulla linea di una possibile guerra fredda. Nella mia città la guerra era una paura ma anche un’attrazione un po’ fascinosa: era vicina, a 5 -10 km dal confine della Ex Jugoslavia, quel confine da cui sarebbe arrivata l’armata rossa. L’atmosfera a Trieste era surreale e non era vissuta così nel resto d’Italia: per esempio il mercoledì mio padre mi portava in Jugoslavia a fare la spesa grande e mi ricordo di aver visto lì per la prima volta il primo kalashnikov imbracciato da un militare. Sicuramente nella Trieste della mia infanzia gli eventi post bellici si vivevano in modo più profondo: l’invasione dei Titini, i 5000 morti buttati nelle foibe e la stessa seconda guerra mondiale erano ricordi molto freschi. Poi iniziai a leggere Oriana Fallaci e il resto è andato come doveva andare.
Afghanistan 1986: 3 ventenni partono per filmare quello che è l’inizio di una guerra epica. Così si diventa giornalisti di guerra?
Io lo sono diventato nella maniera più sbagliata, o forse più corretta non lo so: direttamente sul campo. In quegli anni io, Fausto Biloslavo e Almerigo Grilz eravamo tre ragazzi con il loro sogno: non eravamo di buona famiglia, non eravamo benestanti e non avevamo appoggi politici, anzi venivamo tutti dal Fronte della Gioventù, quindi sicuramente non avvantaggiati da quel punto di vista. Decidemmo comunque di mettere in piedi un’agenzia che chiamammo “Albatross Press Agency”, ci piaceva il nome perchè aveva qualcosa di inglese e di esotico. Ai tempi facevamo solo conflitti e imparammo tutto sul campo, stando con i mujahideen, stando con loro giorno e notte e raccontando le loro storie.
Fu quindi un embedded? Per quanto tutti lo criticano, tu cosa ne pensi?
Beh, si è molto criticato il fatto di raccontare una guerra stando con i soldati ma sostanzialmente è quello che facemmo: stare con un esercito. Per raccontare la guerra è necessario un punto di vista. Alla fine il nostro primo reportage, che non era sicuramente perfetto perchè eravamo alle prime armi, venne comprato dalla CBS per 25 mila dollari e venne trasmesso in prima serata. Noi con quei soldi fondammo appunto l’agenzia e andammo avanti.
Quanto conta la “paura” nel tuo mestiere: è un limite o il motore?
La paura è quella che ti tiene in vita, se non hai paura rischi di finire male. E’ qualcosa che ti divora lo stomaco quando inizi a sentire sparare, ma è la stessa cosa che ti dice di abbassare la testa e cercare di sopravvivere, tenendo i nervi saldi e ragionando anche nelle situazioni più difficili.
Quale è stato il momento in cui hai avuto davvero più paura?
Come dice mia mamma “sono uno scemo di guerra”, quindi sicuramente momenti di estrema paura ce ne sono stati tantissimi anche se non mi hanno fatto quasi mai ripensare alla scelta che ho fatto, perchè sono sempre stato consapevole di ciò a cui andavo incontro.
Un’esperienza particolarmente toccante è quella avvenuta nel Monastero di Maalula in Siria durante una battaglia per il controllo della città che era assediata dai ribelli jihadisti. Riuscimmo ad arrivare all’interno del Monastero dove erano presenti solo suore e un gruppetto di orfanelli ed eravamo pochi: io, il mio interprete Saman – con il quale sono diventato amico e l’ho portato in Italia con me – e 10 soldati. Il comandante che era con noi ci aveva blindato per evitare che i ribelli ci attaccassero ma a un certo punto arrivò una comunicazione via radio dicendo che il comandante era stato ucciso e che eravamo circondati. Ci chiesero che cosa volessimo fare: restare lì? Mi ricordo che Saman mi disse “il primo ad essere sgozzato sarò io essendo cristiano”. Ci sono quei momenti in cui devi fare delle scelte e io decisi per il “allora moriremo tutti insieme”. Decidemmo di aspettare il buio e sfondare le linee in ogni caso e fortunatamente, nonostante i cecchini sparassero, non mi presero. Dopo ci abbracciammo e il comandante mi disse: “vedi, io sono musulmano ma questa volta ci siamo salvati entrambi”. Questo a dimostrazione di quanto la guerra sia un contesto estremo dove, a prescindere da religione o fede, è molto facile vivere le stesse emozioni.
Ci racconti la giornata tipo di un giornalista di guerra?
Nella stragrande maggioranza delle volte è estremamente noiosa perchè, come dico sempre io, siamo gli unici che si vogliono far portare nei posti da cui la gente scappa o dove nessuno vuole portarci. Dobbiamo quindi convincere prima il direttore del giornale o della televisione che stiamo andando a fare un servizio importante e poi sul posto trovare il comandante o il politico di turno e convincerlo a farti mandare in quelle zone. Per esempio in Armenia lo scorso ottobre, andare in prima linea era un serio problema perchè c’erano i droni turchi e chi si avvicinava veniva eliminato, motivo per cui nessun comandante ci voleva accompagnare con il rischio di perdere uomini. Dopo settimane mi venne un’idea: seppi che i preti andavano a benedire i combattenti in prima linea, così ci facemmo amici due di loro che ci accompagnarono e riuscimmo ad arrivare dove volevamo.
Dopo tutti i teatri sanguinosi che hai attraversato, la guerra ti ha cambiato?
Nessuno si rende conto di cambiare ma penso di sì, insomma in 40 anni cambi per forza ed è cambiato anche il mio approccio nei confronti della guerra. Quando sei giovane tutto è diverso, mi ricordo che quando eravamo io, Fausto Biloslavo e Almerigo Grilz ci chiedevamo: “ma se qualcuno viene ferito, dobbiamo soccorrerlo o filmare?” e la risposta ere inevitabilmente “fotografare e filmare, non siamo medici e non potremmo fare niente per soccorrerlo”. E’ in questa atmosfera un po’ allucinata che nasceva anche l’accettazione di una bella morte, fin quando la morte arrivò e fu quella di Almerigo.
Oggi, forse essendo diventato padre e avendo un bambino di 4 anni, mi è molto difficile vedere quello che succede ai bambini, cosa che prima non mi succedeva. La mia sensibilità nei loro confronti è cambiata. Chiaramente poi ci sono anche le conseguenze della guerra, tutti si illudono di no, ma quando inizi a scoprire che di notte sogni la puzza di cadavere ti rendi conto che la guerra ti resta sempre addosso e ti cambia inevitabilmente.
Hai capito cos’è la guerra, ad oggi?
La guerra è sostanzialmente quella condizione dove l’essere umano vive sentimenti e momenti estremi: dove l’odio, l’amicizia e l’amore si estremizzano e dove riconosci quelli che possono essere i veri amici e i nemici. La cosa più bella che mi è capitata in tutti questi anni è quando andammo a cercare in Mozambico il corpo di Almerigo e con noi venne anche un ex ufficiale dell’esercito governativo e mi disse: “vedi, quando il tuo amico venne ucciso io ero lì nella caserma da dove probabilmente abbiamo sparato, ma oggi sono venuto con te perchè la guerra è finita e non siamo più nemici”.
Questo dimostra che la guerra è una situazione transitoria, che deve finire.
L’Italia sta affrontando una guerra da un anno e mezzo, che tu hai anche documentato nelle trincee degli ospedali, come l’hai vissuta?
Io penso sia pericoloso anche il non vivere le guerre: noi abbiamo vissuto come tragedia infinita questa del Covid perchè per la prima volta in 70 anni non avevamo visto una guerra con così tanti morti. Eravamo disabituati, illusi che tutto potesse e dovesse andar sempre bene e questa è una certezza infondata. Io stesso, vivendo nel bergamasco e quindi nell’epicentro iniziale Covid e avendo vissuto anche nel 1995 l’ebola in Congo, mi sono sentito smarrito perchè vedevo le persone disorientate, confuse e incapaci di reagire e questo fa vivere la situazione con ancora più angoscia. In piu, fattore molto importante, lo scollamento della nazione: da una parte queste sensazioni e dall’altra le persone che cantavano sui balconi. Questo ha dimostrato un’incapacità di comunicare la tragedia, anche perchè non conoscendola non riuscivamo ad esprimerla.
Poi, come si vede oggi, ci si abitua a tutto: anche alla guerra.
Rifaresti questo mestiere nonostante quanto sia cambiata la società oggi e di conseguenza il mestiere del giornalista?
Sì, lo rifarei anche se le condizioni sono molto mutate cosa che dico sempre anche ai miei allievi del master in giornalismo alla Cattolica di Milano.
I giovani oggi hanno l’illusione di conoscere tutto premendo i tasti del telefono e poi – inevitabilmente – proprio quando pensano di sapere tutto perchè passano 3 giorni ad informarsi sulla prossima guerra, si rendono conto che le illusioni e le idee che si erano fatte sono ancora più sbagliate di quello che ci immaginavamo noi 30 anni fa studiando su pezzi di carta.
Questo perchè i telefoni, e la tecnologia, propone immagini che non hanno un’anima e quindi non c’è correlazione con la realtà. Il mio consiglio, in ogni caso, come per tutti i lavori giornalistici, è sempre quella di andare sul campo.