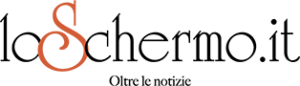Qualche giorno fa ho trovato una lettera aperta di Maurizio Ferraris a Gianni Vattimo sul Corriere della Sera (entrambi filosofi italiani; il secondo, in particolare, ha lanciato l’idea del «pensiero debole» nel solco della corrente ermeneutica ed è un politico della sinistra). E mi è parsa un interessante occasione per continuare una riflessione sul crinale tra scienza e fede che abbiamo cominciato in questo precedente articolo. E di declinarla, questa volta, nel rapporto tra filosofia e fede. Più precisamente, sul rapporto tra una certa filosofia moderna e il concetto di «verità» e su come questo possa essere interpretato, seppure in modo diverso da credenti e non credenti, con un fine comune nell’identificazione di una morale collettiva che sia alla base della nostra società.
Tornando allo scritto in questione, in questa lettera aperta si faceva riferimento ad una seriedi idee e concetti (abbastanza complessi e non del tutto comprensibili neppure a degli «iniziati») su fede e vita. Idee, soprattutto in tema di fede, che erano «vendute» come delle quasi certezze mentre sono totalmente estranee a qualunque insegnamento o rivelazione.
Questo scritto mi ha sollecitato alcune riflessioni e alcune curiosità.
E mi è risuonato in testa il brano del vangelo di Giovanni, nella discussione tra un Gesù debole come non mai e un Ponzio Pilato, potente nella sua relativa gloria di prefetto romano in una provincia dell’impero. Quando, dopo che Gesù si è dichiarato re (“Tu lo dici, io sono re”) aggiunge:
“Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”. Gli dice Pilato: “Che cos'è la verità?”. E detto questo uscì […] (GV 18, 37-38)
Quale è il nesso tra la filosofia del pensiero debole e il brano sopra?
In entrambi i casi si parla del rapporto tra noi e il concetto di verità. Più precisamente si affronta il problema dell’esistenza del concetto di Verità. Se, infatti, Gesù è l’Incarnazione della Verità, Pilato, uomo di mondo e di potere, non crede che possa esistere una verità e non si preoccupa neppure di aspettare una possibile risposta: fa la sua dichiarazione e va oltre a proseguire la sua complessa giornata. Pilato, che non crede all’esistenza della verità, non si discosta molto dagli assunti del «pensiero debole» e quasi ne incarna le ragioni, provando (debolmente) a proteggere il Gesù indifeso dall’ordalia dei fideisti ebrei che poi lo vorranno (e lo otterranno dallo stesso Pilato) morto.
Ma riguardando al percorso che Vattimo fa e alle estreme conseguenze che trae dalle sue tesi, mi sono fatto una domanda: perché qualcosa di astruso e quasi incomprensibile, tanto aggrovigliato da sembrare (per non dire essere) assurdo come lo è la filosofia del «pensiero debole», ha trovato tanto spazio nella coscienza collettiva?
Un preambolo sul pensiero debole e concetto di verità nella filosofia
Ok, anteponiamo un po’ di spiegazioni-nozioni, anche perché non a tutti sarà noto il lavoro di Vattimo. Il «pensiero debole» è una idea filosofica, derivante dal filone del pensiero ermeneutico (di cui parliamo più avanti). Questo parte da alcune posizioni soggettivistiche (in cui, cioè, l’unico valore è «l’io» inteso come unico soggetto che può conoscere il mondo e interpretarlo) e vi collega la teoria che la verità non possa esistere perché sarebbe una violenza alla coscienza. E a tutto questo aggiunge l’idea, tanto cara ad una certa sinistra di pensiero, che il rispetto per l’altro sia fondabile solo ed esclusivamente sul non riconoscere, a nulla e a nessuno, il diritto di reclamare per sé o per altri il titolo di «vero» e «oggettivo». Che poi significa che ogni cosa è contestabile e non esiste nessuna verità.
Il tema dell’esistenza della verità, di una oggettività su cui misurarsi e su cui misurare le nostre azioni, è un tema dalla storia assai curiosa. Insindacabile e scontato per la filosofica greca e latina (seppure, secondo alcuni, lateralmente messo in discussione da sofisti, epicurei e stoici), diviene sempre più centrale negli ultimi secoli tanto da essere la vera trama della riflessione degli ultimi anni.
Ed è proprio l’involuzione in questa riflessione sulla verità, a mio avviso, la principale causa della disaffezione, direi persino della derisione, del nostro mondo verso la filosofia intesa come scienza, percepita come qualcosa di astratto e, a tratti, assurdo. Già, perché la filosofia moderna ha fatto della verità la vittima sacrificale della sua meditazione, negandone progressivamente l’esistenza. Partendo da vari presupposti, dal ruolo dell’uomo nell’universo e dal concetto di superuomo, libero da legami e potente nella sua indipendenza, fino al più modesto ruolo della coscienza e, poi, a quello della percezione, ha successivamente abolito la verità positiva (cioè oggettiva) a favore di un misto di autodeterminazione di «verità diverse» che ha travolto con sé anche la realtà oggettiva che viviamo. Fino a dire che la realtà non è tale ma solo una percezione e, quindi, ognuno ha la sua.
Solo che la consapevolezza, potemmo dire la lezione di vita, che quanto è estraneo a noi sia reale e indipendente dalla nostra volontà è qualcosa che acquisiamo già con la crescita: Il bambino in effetti non ha questa percezione; è da giovani che si matura questa consapevolezza a prezzo di dolorosi incontri con la stessa realtà con cui dobbiamo convivere. Verrebbe quasi da dire, per buttarla in psicologia, che questa parte della filosofia soffre la «sindrome Peter Pan».
Pensiero debole e pensiero scientista: due posizioni agli antipodi
Eppure, limitare la questione ad una involuzione di una logica inconcludente, e quindi non occuparsene per questo, sarebbe sciocco. Perché una delle correnti di maggior successo mediatico (le cui conclusioni influenzano il nostro sentire comune), e della quale Vattimo è esimio esponente, è l’ermeneutica. Termine che poi significa interpretazione. Ossia l’idea che «l’interpretazione» sia la chiave della realtà che, quindi, non esiste autonomamente ma solo soggettivamente. Tradotto: ognuno si può raccontare la realtà che vuole ed è legittimato a sostenerla.
Ed è curioso che sia tanto di moda visto che la nostra è una cultura scientista. Nel senso che riteniamo che la scienza possa esercitare quasi una funzione sacerdotale: intendendo con ciò la capacità di interpretare il mondo, di vedere il futuro e, in ultima analisi, di dirci quali sono le leggi immutabili che regolano la nostra realtà. E vi immaginate se, in un dibattito scientifico, uno se ne uscisse con le tesi ermeneutiche applicate alla scienza tipo:
“È questo il bello della scienza: che ognuno può avere la sua idea sulle cose!”. Sarebbe assurdo, derisibile, perfino grottesco.
Ma è quasi simmetricamente scontato che una discussione sulla morale (su ciò che concerne il bene o il male) o sulla realtà della nostra vita sociale avrebbe proprio quelle tesi come postulato intoccabile, come unica verità a cui non possiamo rinunciare.
Cioè, due mondi completamente opposti, due visioni talmente distanti da essere in palese contraddizione tra di loro, entrambe sono radicate nel sentire comune.
Verità e senso comune: cosa è piaciuto al mondo del pensiero debole
Il tema dell’ermeneutica è diventato, a mio modesto avviso, tanto di moda, nella sua incomprensibile dichiarazione, perché risponde ad un bisogno non sempre cosciente (o forse, con maggiore malizia, dovremmo dire «non sempre incosciente»): scappare dai propri doveri e dalle proprie responsabilità.
E questo è, purtroppo, il vero «senso» del nostro tempo. È l’irresponsabilità ciò che ha segnato maggiormente il pensiero moderno. Quello filosofico, dal relativismo al pensiero debole, entrambe correnti che originano dal pensiero di filosofi del tardo Ottocento come Friedrich Nietzsche e Martin Heidegger che già furono tristemente famosi come base ideologica della prima metà del secolo scorso. Ma anche quello pratico che ha tradotto il tutto nel concetto di amoralità. O, comunque, di abbandono della morale come guida necessaria per la convivenza civile.
Con amoralità si intende il fatto che la morale non è, lei stessa, una scienza positiva e valida per tutti. E questo è una diretta conseguenza della distruzione del concetto di verità: se esistono tante verità, allora non esiste «una» verità cioè non esiste «la» verità. E se non esiste «la verità» non esiste neppure «la morale» ma ognuno, che ne senta il bisogno, può confezionarsi la «sua» morale. Peccato che se non c’è la morale non c’è più neppure la base del vivere civile né il presupposto per la fiducia negli altri e nei loro comportamenti.
È il dilemma dei nostri giorni: vorremmo che «gli altri» si comportassero bene. Vorremmo che i politici si attenessero a comportamenti morali. Ma poi non vogliamo che si definisca una morale. Non accettiamo l’idea che possa esistere una autorità morale (persona o collettività) che possa dirci se una cosa sia giusta o sbagliata. Che possa dirci se «noi» facciamo una cosa giusta o sbagliata. E, soprattutto, desideriamo di sentirci «giusti», o almeno «giustificati», anche quando facciamo cose che ci fanno piacere o comodo ma che sappiamo essere sbagliate. Vogliamo poter cancellare tutto con un tratto di penna sulle regole, che è più facile che sopportare il peso di scelte sbagliate fatte in piena coscienza delle nostre azioni.
Ci piace, così, sostenere la morale del più furbo. La morale a elastico, che si allarga e si restringe al bisogno. Solo che una tal morale non lega più nulla. Non garantisce il comportamento di nessuno. Non giustifica neppure più noi stessi.
È quindi il rifiuto di una morale che possa metterci davanti al concetto di errore che spiega il successo di dottrine filosofiche tanto opposte al nostro vivere comune. Perché colpire il concetto di verità annichilisce il concetto di morale. E che sia la morale il vero obiettivo lo connota anche uno dei più importanti assunti della filosofia ermeneutica: che il concetto di verità è un’offesa alla libertà del soggetto. Idea che Vattimo incarna nell’«Oltreuomo»: un soggetto diverso, non più sobbarcato dal peso della responsabilità, né potenzialmente colpevolizzato da etiche intolleranti.
Il fondamentale ruolo della morale nella società
Ma non vi è vita sociale ordinata senza una morale collettiva. E non esiste morale senza il riconoscimento di una verità collettiva, di una realtà che possa essere sottratta alla soggettività di definizione e sia universale. E, decisamente, non è vero che una morale collettiva debba essere escludente o violenta o, comunque, non aperta all’altro.
Per un credente questa oggettività è riposta nel concetto di Dio. Per un cristiano, in particolare, nel concetto di un Dio che è talmente coinvolto nella storia dell’uomo da volerne far parte materialmente con l’incarnazione. E c’è del vero nella pretesa (ermeneutica) di dire che la verità assoluta, cioè senza veli, distrugge la coscienza. E che la percezione dell’uomo è incompleta e parziale. Ma lo è perché anche la parte di verità che riesce a comprendere è incompleta (limitata) e parziale. Ed è precisamente questo il motivo per cui la «rivelazione» è comunque «incarnata» quasi nascosta. Non è nella «gloria» di un Dio manifesto che, altrimenti, non lascerebbe spazio alla scelta che è la condizione per l’amore, fine ultimo del Dio cristiano. È nella manifestazione «debole» che la scelta si conserva, che la fede si esercita e che l’amore trova il suo necessario spazio. Ma il nascondimento, come anche il limite che abbiamo nel comprendere, nulla toglie alla realtà dell’esistenza di una verità totale, di una perfezione assoluta. E quindi non impedisce di sviluppare una morale. E, anzi, porta ad una morale accogliente, capace del concetto di perdono e di pazienza come anche di marcare la differenza tra peccato e peccatore, tra atto ed essenza della persona.
Per il non credente questo percorso è, naturalmente, più difficile. È più faticoso trovare il concetto di assoluto fuori dal concetto di Dio. Ma lo si può trovare, almeno in parte, in un universo regolato da leggi razionali. Lo si può trovare anche nel riconoscimento del valore degli altri e della loro soggettiva esistenza. Lo si può trovare nella riflessione sul valore di sentimenti come affetto e amore che ci legano gli uni agli altri e, in modo speciale, nelle comunità familiari.
Ma comunque, difficoltà a parte, si può trovare, e, nella storia, si è sempre trovato, un supporto al concetto di morale da utilizzare proprio nella gestione della vita comunitaria e senza la quale l’idea stessa di comunità fatica a stare in piedi. Perché, nella storia, ogni volta che una civiltà ha abdicato al concetto di morale, è poi collassata su sé stessa.
È cioè vero il contrario delle tesi del pensiero debole: senza una verità collettiva, da cui scaturisce una coscienza collettiva che, per esistere, necessita di una morale condivisa (e quindi collettiva), non c’è il presupposto per la tutela dell’altro, del debole, dell’equità. E senza queste tutele le società diventano egoiste, edoniste, più polarizzate e divise al loro interno. E poi, invariabilmente, collassano.
La riflessione sulla verità e sulla morale, così derise e snobbate dalla nostra cultura mainstream, sono quindi non solo necessarie ma vitali per riaffermare una nostra visione di vivere civile che, indiscutibilmente e nonostante qualche inciampo, ha ottenuto grandi risultati. E che oggi più che mai si trova davanti a sfide di dimensioni globali.
Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi