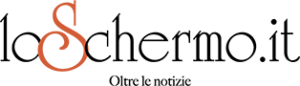Ieri al pronto soccorso c’erano due ragazzi. Piccoli infortuni da trauma per entrambi, fortunatamente nulla di serio. Sono entrati la mattina verso le 8.00. Hanno atteso.
La storia che vogliamo narrare è di quelle che avvengono quotidianamente. Racconta una situazione di cui siamo più o meno coscienti tutti quanti. Ma alla quale ci siamo un po’ rassegnati. È il risultato di anni di progressivo peggioramento delle prestazioni mediche a fronte delle quali non ci sono proposte vere, non ci sono progetti.
La storia ve la immaginate già da soli. Questi ragazzi entrano con traumi simili. Hanno codici «lieve» perché non sono certo in condizioni gravi o con rischio di peggioramento. Quasi insieme fanno il triage, dopo oltre un’ora e mezza, poi, dopo diverse ore, uno viene dirottato in ortopedia, l’altro rimandato in sala di attesa. Il resto della storia è quello che vi aspettate. Il primo è più fortunato: se la cava in «appena» sei ore riuscendo ad uscire con una radiografia, una medicazione e una diagnosi prima delle 15.00. l’altro ha meno fortuna e resta incagliato al pronto soccorso fino alle 18.00: dieci ore di «soggiorno».
Precisiamo subito che la nostra non è tanto una storia di malasanità nel senso di medici o infermieri che non fanno il loro dovere. Il problema è peggiore perché è più strutturale.
Ciò che ci ha colpiti dai racconti che vi abbiamo riportato, non era tanto il tempo di attesa: esagerato per il primo caso e quasi doppio nel secondo. Secondo che, sia detto per inciso, era pure arrivato per primo al pronto soccorso. Questo al massimo racconta una strana organizzazione delle priorità di intervento. Ciò che ha colpito è il racconto di quanto visto all’interno del pronto soccorso stesso.
È stato il racconto degli spostamenti da e verso il PS per fare le visite specialistiche. Proviamo ad immedesimarci.
Sala di aspetto.
La noia di un’attesa che si annuncia lunga è la compagnia che qui hanno tutti. C’è un di-qua e un di-là. La porta. È il muro di separazione, il diaframma che separa da un’agognata fine della noia. Le regole del Covid sono un ricordo di qua. Lo spazio è poco, le persone sono tante. Oltretutto chi attraversa la porta lo deve fare da solo: nessun parente è ammesso. Sembra una regola residua dei tempi del Covid ma, scopriremo poi, ha probabilmente altre motivazioni.
Nella noia l’unica cosa da fare sono i cellulari. Ma anche quelli sono un problema: il funzionamento è incerto; il segnale varia a seconda dei gestori: dallo scarso con problemi a fare una telefonata di Vodafone all’assente di Iliad. Tutto quello che ti resta da leggere è il monitor con i nomi delle persone già dentro. E fa un po’ impressione: sono due pagine di un monitor messo in verticale. Saranno almeno una quarantina.
Poi, ad un certo punto entra un dottore. Dice: “tutti quelli con problemi oculistici vengano con me!”. Un gruppo si separa dal resto e via, in mandria oltre il diaframma della speranza. La sala si svuota un po’ ma non tanto. Fortunati, verrebbe da dire se non suonasse sinistro nel luogo in cui ci si trova.
Poco dopo una infermiera viene e chiede a chi tocca. E qui c’è da ringraziare un certo fair play degli astanti, ma un po’ di organizzazione non è che guasterebbe: un numerello per l’accesso al triage o una persona che si occupi di far passare avanti chi è più urgente sarebbe anche qualche cosa che ti aspetteresti.
Il bene di valore nella sala del pronto soccorso sono le informazioni: nessuno le ha, tutti le cercano. Si vuole sapere quanto attendere, come stanno le persone dentro, quanto tempo ci vorrà ancora. Tante domande, nessuna risposta. Solo che «verrete chiamati». A voce per accedere al triage; al telefono per informazioni su chi ha attraversato la porta. Come sempre, chi è più sfrontato ottiene di più. Chi insiste maggiormente, al limite del maleducato, per sapere, poi viene ricontattato; chi attende con più calma, fa esercizio di pazienza e vede altri arrivare prima al risultato. La mancanza di file gestite comporta inevitabilmente anche questo.
Anche per non farsi prendere dal nervoso si torna a distrarsi con il monitor dei pazienti che sono dentro la struttura. Una visione monotona e quasi ipnotizzante. Almeno per i nostri protagonisti che hanno la fortuna di essere lì solo per piccoli incidenti.
Ma non per tutti è così. Mentre si è là capita di assistere a scene toccanti, quasi crudeli. Come quella di un uomo anziano che si avvicina al gabbiotto dell’accettazione. È avanti con gli anni e chiede di una sorella che è oltre la porta e, immaginiamo, sia anziana anche lei.
Non sanno dirgli nulla. Non lo sanno mai. Lui è visibilmente preoccupato.
“Per favore, fatemi sapere qualche cosa. È da sabato che è ricoverata qui al pronto soccorso! Tre giorni! Da allora non sappiamo nulla. Al telefono non ci dicono nulla, qui nemmeno. Almeno diteci se è viva o morta”.
Scene toccanti alle quali, naturalmente, non resta indifferente neppure l’OSS che va dentro e cerca di reperire informazioni.
Poi si entra. I primi passi sono scioccanti. Non c’è lo spazio per passare adeguatamente: i corridoi sono pieni di barelle da ambulanza con persone sopra. Il percorso assomiglia a quello che ti aspetteresti in un ospedale di campo: persone che sono sole, all’apparenza abbandonate a sé stesse, spesso senza neppure avere certezza che si tratti di persone vive. Solo che non si tratta di feriti di una zona di guerra ma normali malati ammassati lungo i corridoi come fossero merci in un magazzino. I più fortunati sono quelli che hanno un posto nelle stanzine. In quattro o cinque in uno spazio per due. Gli altri dove è possibile. Su barelle leggere da ambulanza. Sono scomode anche a vedere.
Torna in mente le parole di quell’uomo all’accettazione: se una persona è stata su quella barella per due giorni deve aver patito parecchio.
Per lo più si tratta di anziani. Alcuni sono con il lenzuolo tirato sul viso. Probabilmente se lo sono tirati sul viso da sé stessi un po’ per privacy un po’ per isolarsi dalle luci del soffitto.
C’è una donna che si lamenta con un’infermiera: sua madre è anziana e non è in testa. Dice che è rimasta senza cibo né acqua per un giorno intero. Non si fa fatica a darle credito. L’infermiera risponde che non possono darle nulla se non c’è un medico che autorizzi. Si va oltre e non sappiamo come finisce la discussione. L’unica cosa che è certa è che non è sano tutto questo. Non lo è per i malati. Non lo è, ne siamo convinti, neppure per chi deve lavorare là dentro.
Alla fine la storia è anche banale e facile da dimenticare. Quello che si è visto dentro no. Il vecchio ospedale, il Campo di Marte, era più capiente: certe cose non le vedevi. Il nuovo, il San Luca, doveva funzionare meglio: non pare che sia così. Le promesse di miglioramento che sono state sparse quando doveva essere costruito sono rimaste tali: promesse. Il nuovo stato della nostra sanità è peggiore del vecchio che certo non era entusiasmante.
La sostenibilità. È questa la riflessione che ci viene da fare. Abbiamo un sistema sostenibile? Siamo in grado di pagare un sistema sanitario come il nostro? Vale la pena di pagare questo sistema sanitario?
Tutti noi paghiamo molte tasse, è certo. E tutti i politici, di destra e di sinistra, dicono che sono troppe, che andrebbero abbassate ma che di certo non possiamo aumentarle. Ma abbassando la spesa il servizio è questo. E peggiora. Aumentandola non si capisce cosa dovremmo tagliare per non aumentare le tasse. E allora la domanda è: come se ne esce?
Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi
Foto di Pixabay