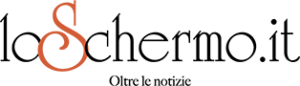C’è una nuova generazione che non sa che cosa sia davvero l’11 settembre. Cioè, magari hanno anche letto qualcosa, ma non lo sanno davvero.
Ognuno di noi, che ha qualche anno più dei 35, ricorda che cosa faceva quel giorno. Perché fu un trauma. Un momento che lascia il segno nella vita.
Io ero in un aeroporto. Il che rese il tutto ancora più surreale. Ero a Roma, di scalo tra due voli. E vedere tutto dai televisori delle sale di aspetto, vedere degli aerei simili a quelli su cui ti stai per imbarcare o da cui sei appena uscito, che si schiantano ripetutamente contro edifici civili, beh, fu decisamente traumatico.
Ma lo fu anche per chi non era in un aeroporto. Lo fu per tutti. Fu una specie di momento di perdita dell’innocenza collettiva. D’improvviso ci sentimmo tutti più vulnerabili, più esposti.
Vedere la lenta agonia delle torri; l’orrore delle persone che morivano in diretta tv, poco alla volta, gettandosi nel vuoto, scegliendo di morire così piuttosto che bruciati o soffocati; vedere tutto quell’orrore “lento”, che si sviluppava poco a poco, ha distrutto l’idea un po’ ingenua che il mondo, nonostante tutto, si stesse rimpicciolendo, che tutti ci stessimo avvicinando.
Non che prima non ci fossero guerre; non che non ci fossero orrori. Ma la sensazione era che una civiltà in espansione avrebbe, magari lentamente ma inesorabilmente, portato tutti verso un mondo più aperto, inclusivo e, in fondo, migliore.
Certo, c’erano anche coloro che lottavano contro la globalizzazione. Ma erano posizioni minoritarie.
La visione del mondo era ottimistica.
Poi arrivarono gli aerei. E con le torri crollò anche il nostro ottimismo.
E arrivò la guerra. Quella che i terroristi avevano portato nel cuore dell’occidente (a New York) e quella che fu portata per rispondere all’attacco. Che, onestamente fin da subito, apparve come una ritorsione. Una risposta militare a quella che era un’aggressione terroristica e, come tale, impossibile da collocare fisicamente in un posto e in un luogo. Ma il dolore di una nazione (che si era propagato ad una parte del mondo) chiedeva un capro espiatorio.
È stata una svolta. C’era un prima e poi c’è stato un dopo.
Prima il mondo stava diventando più sicuro (o almeno questo era quello che ci si aspettava). Prima l’Europa si era riunita sotto una sola moneta; si erano rafforzati i legami di cooperazione; la Russia belligerante era un fantasma del passato (vicino, vicinissimo ma passato), la Cina si apriva al dinamismo dell’economia, l’India sembrava vicinissima all’America e il mondo sembrava destinato ad avviarsi verso un giorno radioso sotto la pax americana. Ci potevano essere dubbi su tutto questo, e c’erano in molti ambienti, ma erano più di tipo morale che sul destino della storia.
Dopo il mondo era pericoloso. Dopo c’è stata la guerra, con le sue logiche. Dopo scoprimmo che esisteva al-Qāʿida. Dopo c’è stata l’invasione di Afganistan e Iraq. Gli attacchi terroristici in vari continenti e contro i più disparati obiettivi continuarono di pari passo con la guerra. E anno dopo anno divenne chiaro che, per quanto potente fosse la macchina militare messa in campo, il risultato che si voleva era irraggiungibile.
Perché, nonostante tutto, nonostante che fossero evidenti anche delle contraddizioni aperte, lo scopo delle operazioni era anche di provare a stabilizzare un’area. Di provare a cambiare le cose spazzando via una classe dirigente per favorire una normalizzazione democratica. E, per quanto fosse evidente che non fosse né l’unico scopo né quello che aveva giustificato il via all’azione, è certo che i paesi occidentali avrebbero voluto che l’Afghanistan e l’Iraq avessero delle svolte democratiche. Sarebbe stato la perfetta conclusione di tutto; la giustificazione postuma che avrebbe salvato l’anima di tutti davanti alla Storia; il risultato che avrebbe cancellato ogni errore, ogni nefandezza. Un simile estio, se avessero potuto ottenerlo, se fosse mai stato davvero alla portata, tutti i governi occidentali lo avrebbero sottoscritto.
Ma la guerra del nuovo millennio ha insegnato che, dopo Europa del ‘45 e Corea ne ‘53, nessun paese che ha subito una guerra portata da fuori, anche con le migliori intenzioni, ha saputo sintetizzare una vera democrazia.
Così siamo diventati cinici. Abbiamo smesso di credere che le cose fuori dai nostri confini possano cambiare. La nuova Russia di Putin e l’evoluzione della Cina di Xi hanno confermato l’impressione che il «mondo esterno» sia irriformabile, insanabilmente antidemocratico e pericoloso; che non possa essere salvato.
È il nostro pessimismo. È la nostra convinzione che abbiamo tratto dagli ultimi decenni dove gli USA non sono più faro di democrazia ma mercanti che sfruttano la loro posizione; l’Europa non è più la nuova frontiera della sperimentazione della convivenza tra stati ma è diventata la ridotta da cui difendersi da un mondo feroce. E dove gli altri, i paesi instabili e guerrafondai, sono diventati pericolosi, aggressivi e, ora lo sappiamo, impossibili da normalizzare. In una parla, nemici implacabili e inesorabili. Nemici da cui difenderci, da cui stare il più possibile lontani.
Oggi non siamo neppure più fieri delle nostre democrazie. Non siamo neppure più convinti che il nostro sia il modo migliore di vivere.
In questo Osama Bin Laden ha fatto centro, probabilmente anche più delle sue aspettative: ha distrutto la fiducia dell’occidente in sé stesso.